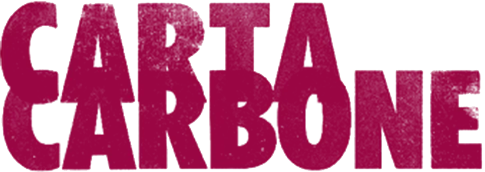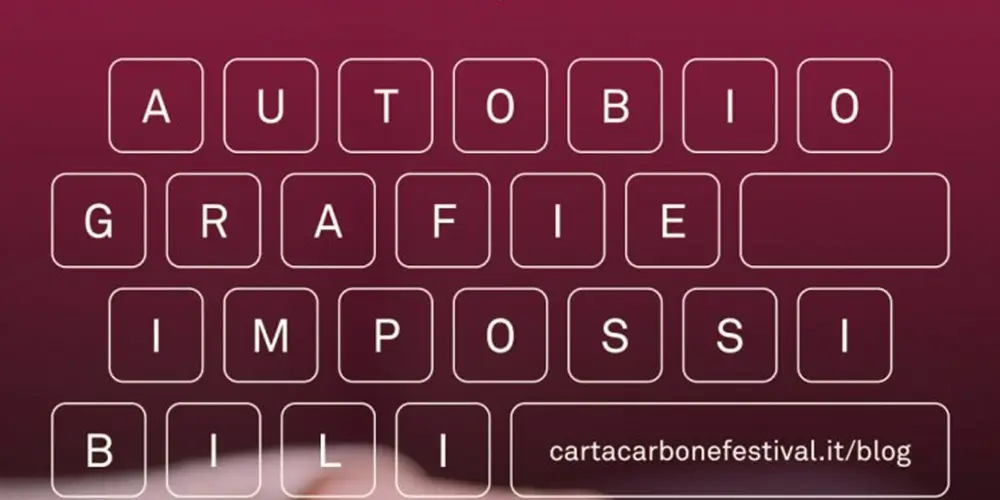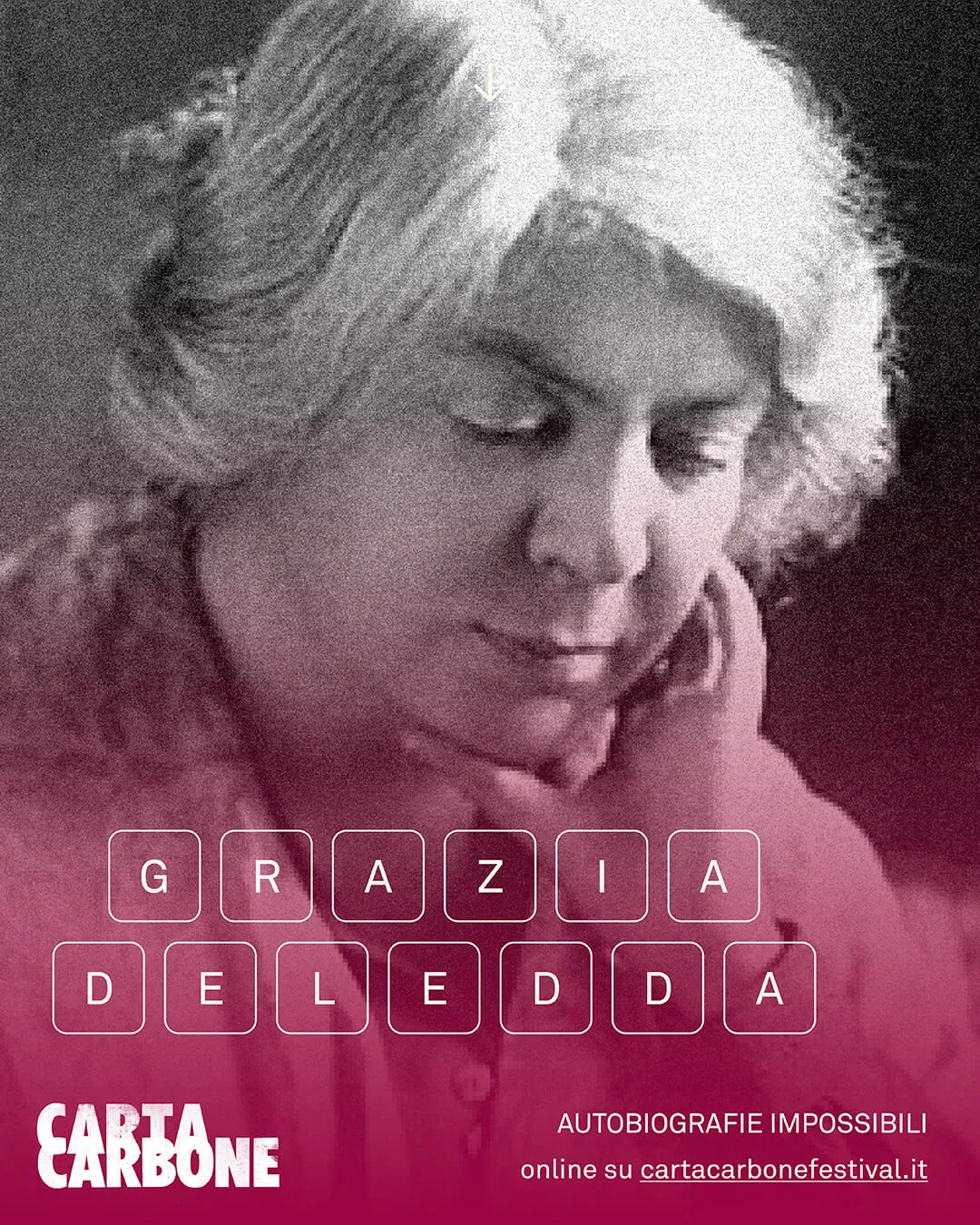La scelta del nome “Autobiografie impossibili” non è certo casuale. Si tratta di un omaggio a “Le interviste impossibili” di Giorgio Manganelli che furono il frutto della vivace collaborazione dello scrittore e giornalista milanese con alcuni dei nomi più rilevanti del panorama letterario italiano. L’opera consiste in una raccolta di interviste immaginarie a personaggi storici famosi ormai deceduti con i cui fantasmi Manganelli s’intrattiene per una conversazione. Ma l’idea di raccontare in prima persona episodi della vita di grandi scrittori e grandi scrittrici nasce successivamente alla scoperta, scovato in una polverosa libreria d’una casa di campagna, della “Storia universale dell’infamia” di Jorge Luis Borges.
Così, a metà strada tra l’esercizio di stile e la volontà di onorare il ricordo di alcuni dei più importanti autori dell’umanità, si è deciso che non sarebbe stato poi così indegno far rivivere quest’ultimi nelle fantasie di autori certamente meno degni, ma non per questo meno appassionati. Ecco allora che magicamente rivedranno la luce gli scritti autobiografici perduti dello stesso Borges, quelli di Jack London, di Ennio Flaiano, di Grazia Deledda, di Italo Calvino, di Jules Verne, di Albert Camus, di Théophile Gautier. E questi sono solamente i primi nomi che ci sono venuti in mente. La lista sarà davvero lunga, perché, se basteranno le fantasie vaghe di alcuni scrittori più o meno sconosciuti, si potrà dar vita ad uno sconfinato universo di storie perdute, mai narrate. Un gioco pericoloso. Bugiardo, all’occhio più giudicante. Un carosello di vite rubate, rimestate e ricomposte, aggiustate, innestate. Ma il nostro desiderio non possiede alcuna malizia. Ci presentiamo disarmati e invitiamo il lettore stesso a giocare con noi, al modo in cui da bambini si decide di vestire i panni di un supereroe, ampliando il ventaglio di storie di cui esso si trova protagonista.
Manganelli, nel suo saggio “La letteratura come menzogna”, afferma, appunto, che la letteratura sia una menzogna. La mendacia, la mistificazione, sono quanto genera la letteratura e, nonostante possa sembrare in contraddizione, la rendono vera, addirittura ne giustificano la sua esistenza. Il saggio di Manganelli non è di facile approccio, ma la materia trattata ne “La letteratura come menzogna”, per lo meno nel primo capitolo dell’opera, cerca di dirimere l’annoso dibattito che contrappone verità e menzogna nella letteratura, tentando di andare oltre. Questo dibattito è uno dei cardini sopra cui si è costruita una porzione non indifferente della filosofia della letteratura. Un nome sovviene alla mente quando si cerchino risposte forse più immediate di quelle che si dà Manganelli: Walter Benjamin.
Pensatore profondo quanto semplice, nell’accezione migliore del termine sia ben chiaro, Benjamin diceva che la verità in una storia si può trovare quanto più saldo risulti l’accordo di finzione tra il narratore e il lettore. È proprio quando si è consapevoli che gli eventi narrati sono frutto di una finzione, veri quindi nella loro menzogna, della quale i lettori possono fidarsi ciecamente, che si finirà per imparare qualcosa. Basta un briciolo di mendacia in una verità per renderla a tutti gli effetti una bugia. E nulla potrebbe disporre meglio il lettore a un’interpretazione scevra d’ogni giudizio “sentimentale” quanto la certezza che le righe che scorrono sotto ai suoi occhi sono certamente frutto di un’ invenzione. Si ammetta di giocare sopra a un palco.
Insomma, in questi termini, l’autobiografia potrebbe risultare come una delle narrazioni che non custodiscono la Verità (almeno intesa come messaggio trasmesso nella sua forma più pura).
Quanto d’altronde noi stessi, quando vogliamo raccontare una memoria antica, finiamo non poi così raramente per inquinarla con fantasie o addirittura memorie altrui? Non per questo si vuole qui affermare che l’autobiografia sia un genere in nessun modo meno degno della fiaba, o dell’epica, che Benjamin poneva come primi custodi della verità nella narrazione . Ma se si leggerà un’autobiografia con la pretesa di obiettività, con attitudine1 oggettivista, si rischierà di non cogliere appieno, se non di stravolgere totalmente, il contenuto di quanto si sta leggendo. A quel punto il messaggio ulteriore, quello proprio della letteratura che non limita il suo ruolo alla trasmissione della nozione, potrebbe non essere ricevuto dal lettore in questione. Anzi è proprio la tendenza a trattare l’autobiografia come una storia denotativa, una cronologia, una carta carbone (mi si perdoni l’inopportuna citazione) dell’immagine reale del narratore, a negare, almeno parzialmente, il valore intrinseco di questo tipo di narrazione.
Sperare di trovare la verità quando l’accordo di finzione non sia ben definito richiede certamente di prestare maggiore prudenza nella lettura. Anche approcciandosi all’autobiografia il patto narrativo di finzione deve essere sancito e non dimenticato. Questo perché difficilmente si decide di raccontarsi diffusamente con la mera volontà di registrare la nostra stessa esistenza; un commento soggettivo, una rielaborazione, sia esso di forma o di contenuti, è d’obbligo.
L’autobiografia è volontà didattica2, differente, nella maggior parte delle sue espressioni, da altre forme di autobiografismo, come un diario oppure, in estremo, il racconto orale di un evento accaduto a chi racconta. Anche il diario a onor del vero potrebbe possedere una certa misura di programmaticità, ma non organica e lungamente riflettuta come quella propria dell’autobiografia. Di solito l’atto dell’autobiografia possiede un criterio maieutico, in molte forme. Vuole essere esempio, negativo o positivo, un atto narrativo generico d’intrattenimento, dotato o privo di morale, nato però dalla scusa di una vita vissuta, un’educazione alla bellezza o all’orrore, anche alla bellezza dell’orrore e viceversa; uno sfogo fortunato e forse pure un desiderio di essere ricordati secondo una certa prospettiva, anche se abbiamo sempre sospettato che questa motivazione fosse la più rara, in accordo con il carattere volentieri dignitoso degli scrittori.
Detto questo l’autobiografismo rappresenta una delle narrazioni primigenie. Con ogni probabilità una delle prime cose raccontate nella storia sarà stato un accadimento cui si è assistito, la caccia di un bufalo, la morte di un compagno, un fulmine che ha colpito un albero. È una delle disposizioni più naturali e, quando essa si cristallizza nella forma complessa dell’autobiografia, ne perde in immediatezza e, pure, in sincerità. Nessuno potrà ipoteticamente verificare quando raccontato e il narratore stesso, come già detto, tenderà ad una rielaborazione, volontaria o meno, dei fatti. Raccontare sé stessi è un atto di coraggio. Richiede, appunto, sincerità (arma difficile da maneggiare) e uno sguardo puntato sulle proprie paure. Ma la carta giunge in aiuto: è un dialogante muto, che non giudica e non arresta l’indole (accetta tutto, verità e menzogne e tiene per sé tutti i segreti, consapevole della missione dello scrittore). Per questo spinge alla confessione. Le pagine vuote possono accogliere molto di più di chiunque altro, a volte anche più di quanto possiamo contenere in noi stessi.
Di questa menzogna, garante della verità, della fedeltà della carta, noi ci facciamo doppiamente scudo. Contro la storia, quella precisa, e contro la paura, quella di parlare a nome di qualcun altro. Queste sono le promesse/premesse al progetto. Una giustificazione che nega sé stessa, perché non ha bisogno di esistere. Non racconteremo nulla di vero e nulla di falso, racconteremo solamente quello che ci è stato insegnato, provando a emozionarci e a suggestionarci, nella speranza che possa accadere anche a chi leggerà queste “Autobiografie impossibili”.
_________________________
1Benjamin spiegava che la fiaba, in virtù della sua natura assolutamente estranea alla pretesa di realtà, riusciva meglio di ogni forma di narrazione nell’evitare che i lettori, o gli ascoltatori, fossero distratti dalle implicazioni della verosimiglianza. Quello che la fiaba voleva insegnare passava direttamente. Un perfetto canale di comunicazione tra la saggezza comunitaria e gli individui, perché ogni cosa raccontata viene rappresentata da stereotipi, forme pure di idea, che non hanno bisogno di spiegazioni e conferme.
2Nel saggio in appendice all’Angelus Novus, “Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nicola Leskov”, si definiva il narratore come uomo di “consiglio”, ovvero quanto può generarsi da una vita vissuta e che si tramuta in saggezza. Questa è più facilmente assimilabile dalla letteratura nata in seno alle comunità: le fiabe, le novelle, le leggende popolari. Ma la saggezza, «il lato epico della verità» dice Benjamin, è andata via via perdendosi nei secoli, con l’evoluzione della società umana. Sono nate nuove forme di letteratura, non meno belle, ma dalle quali è più difficile trarre consiglio, perché nascono da singoli individui. Una narrazione che banalmente si complica, diventa ampia, ricca di particolari e riflessioni, che passeranno nel filtro del giudizio del lettore moderno, il quale dovrà essere sempre più critico, specialmente con sé stesso, per poter imparare qualcosa da ciò che legge.
— Alfredo Baggio —