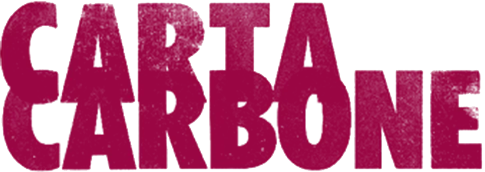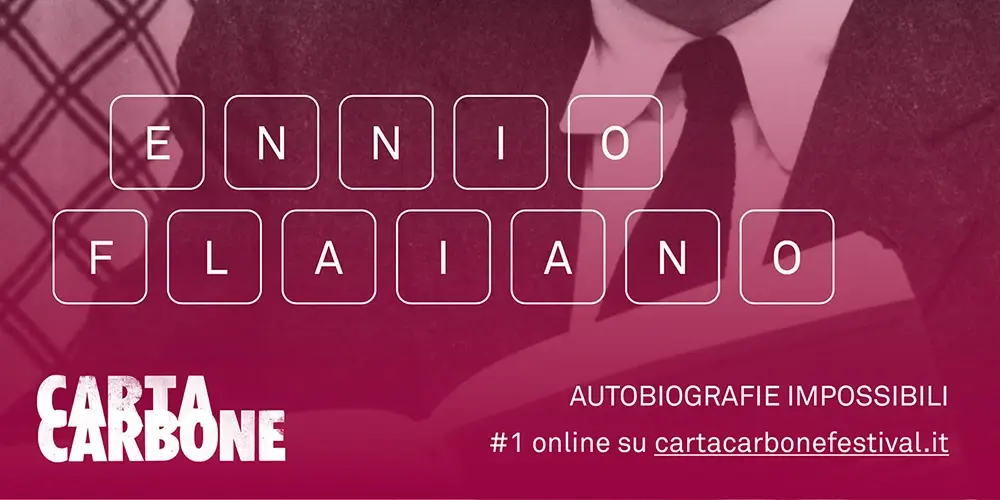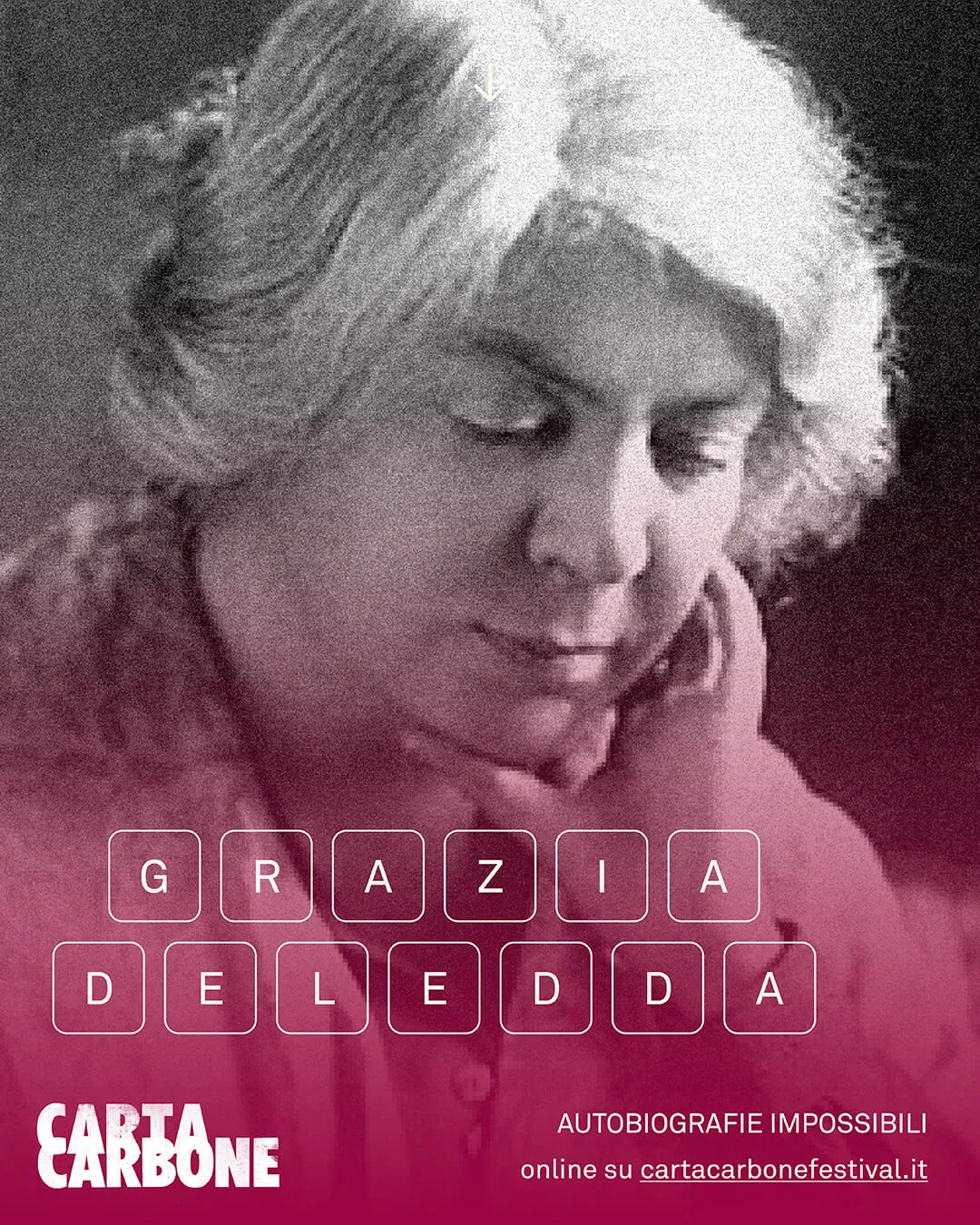Sembra affascinante, ma di un fascino dozzinale, che può attecchire con le casalinghe al mercato del pesce; male che va, sulle aringhe. È sguaiato nella sua eleganza posticcia. Di chi ha visto negli altri l’eleganza, o la sua ostentazione, ma non sa cosa significhi avere una propria eleganza. Insomma, manca del concetto di stile. Non che si vesta male, anzi. La giacca chiara di lino, la camicia azzurra, i chino color cachi e i mocassini di pelle sono gli stessi, e voglio dire esattamente gli stessi, che si possono vedere nelle vetrine di via del Corso in centro. Se non fosse per il cappello e gli occhiali da sole scuri, per nascondere agli altri l’opportunità di discernere il suo vero intento e il suo vero pensiero, sarebbe indistinguibile dal manichino; il quale, a quanto posso vedere, deve essere stato il suo maestro nella nobile arte di mantenere una posa plastica per minuti, ore perfino, quando qualcuno d’importante lo sta guardando, quindi è d’uopo fare buona impressione. Il suo strumento di lavoro, che si porta sempre dietro, è l’accessorio che sfoggia con massimo orgoglio, quando le circostanze sono favorevoli, ovviamente. Ma anche quando sono avverse, la tiene con sé, nella sua borsa. Non è un semplice strumento del mestiere, ma la sincretizzazione fisica del suo status sociale e morale. C’è sempre da stare attenti, se si può guadagnare. Non si sa mai chi puoi fotografare. È sguaiato, maleducato nell’esercizio della sua professione. Ci vuole un nome adeguato. Gaetano Paparazzo. Non so, anche a livello fonico, quando viene pronunciato, mi piace, la bocca s’impasta bene. Paparazzo. Produce lo stesso fascino del suo portatore, come una parola inventata da un bambino per gioco, un capriccio acustico che ti si appiccica nel cervello e ci resta, anche se non si vuole. Soprattutto, anzi, per più tempo quanto più risulta sgradevole. È una chimera, l’archetipo del nostro tempo tragicomico. Gaetano Paparazzo. È d’una serietà estrema, marziale, nel suo essere faceto. Una cultura millantata sapientemente, con silenzi assensi, occhiate eloquenti da dietro le lenti nere, citazioni (apocrife, a quanto ne so) da Verlaine; in un francese da vero madrelingua. È una persona che sembra misteriosa, piena di segreti interessanti, che non si scopre mai, ed esercita la sua (s)gradevole gravità su tutti coloro che la guardano; ma, in realtà, è una persona superficiale, ignorante, piatta, come il riflesso della luna su una pozzanghera, che viene scambiato per la luna stessa.
Non è una persona, è un individuo. Anzi, un’incomprensione tra due tempi che si accavallano nello stesso presente. Il frutto dell’abuso di una civiltà su un’altra civiltà. È il figlio della violenza. Una violenza invisibile e piacente.
Mah, forse così è un po’ troppo. Non è credibile. Ricordati: deve avere anche dei difetti. Chi è Gaetano Paparazzo? Il primo attributo che bisogna citare quando si parla di siffatto uomo è che non esiste. In realtà esiste un Signor Paparazzo, ma non è il Paparazzo di cui stiamo parlando. Il vero Paparazzo è un albergatore calabrese, molto ammirato e apprezzato da George Gissing, che lo cita con affetto nel sempreverde Sulla riva dello Jonio, libro da cui io e Fellini abbiamo estratto a caso il nome. Nel film che stiamo scrivendo insieme a Pinelli, il suo personaggio è, se non proprio un coprotagonista, una sorta di contrappunto al protagonista. Quanto a questo, abbiamo pensato di restare fedeli all’idea originale, ovvero quella del giovane provinciale emigrato a Roma per intraprendere la carriera giornalistica. A passeggio per Via Veneto, mentre contemplavo la macilenta atmosfera festaiola che infesta gaiamente la strada, questa sera ho imparato qualcosa di nuovo su ognuno di questi due signori. Entrambe le cose però derivano dalla medesima osservazione. Tutto è partito dalla semplice constatazione che il cambiamento che ha avvolto la nostra società, si manifesta in maniera più evidente qui. Forse è per l’intrinseco dualismo della città che, confondendo sacro e profano, riesce a sopravvivere alla decomposizione perenne che la rende eterna; forse è per il clima subtropicale, che rende tutto più selvaggio, sfocato, aggressivo. Anche questo cambiamento riesce più aggressivo, come procedesse per intensi raptus evolutivi, in cui fagocita e digerisce tutto ciò che era prima. È come quando si va al museo di storia naturale, dove si possono guardare i diorami che riproducono un piccolo nucleo sociale ideale, paradigmatico, da cui si dovrebbero evincere cultura, rapporti di potere, estetica, morale e sfrenate passioni di un gruppo di esquimesi che scavano un buco nel ghiaccio, per esempio. Roma è il diorama della parabolica evoluzione nazionale. E al suo interno, un altro diorama, ancora più circoscritto, ancora più sintomatico. Una rappresentazione perfetta; e, come ogni rappresentazione, non c’è spazio per le persone, ma solo per ruoli e schemi da ricomporre. Il nostro pigro destino ci ha spiaggiati al mare; sempre e comunque, a quanto pare.
Abbiamo trasformato le strade in spiagge, senza sabbia e senz’acqua, ma con la canicola e gli ombrelloni da lido che tumulano allegramente lo spazio prospiciente ogni bar. Ogni gestore ha esercitato il suo gusto cromatico, tutti scegliendo abbinamenti quanto più accesi e cangianti possibile, per rappresentare con il giusto entusiasmo la propria impresa. Sicché via Veneto, con la giusta prospettiva, sembra una luminosissima collana floreale delle Hawaii. Questa balnearizzazione della città, dei costumi, delle conversazioni perfino, mi ha fatto ricordare, per contrasto, la prima volta che sono andato a Ostia. La sobria desolazione nostalgica del mare primaverile si infrangeva nella triste esuberanza della sua riproduzione urbana. Ero con una donna, e da bravo giovane emigrato di provincia, mi era scappato di chiamare il lido (l’unico che c’era fino all’orizzonte) chalet, come si usa dire dove sono cresciuto; la donna aveva riso e preso in giro il giovane emigrato di provincia. Ho pensato che il protagonista, arrivando per la prima volta a via Veneto e vedendo gli ombrelloni, si sarebbe potuto sentire come mi sono sentito io a Ostia, disperso di fronte al fascino di una donna di città che vede solo un ragazzotto di campagna, anche se ben educato e istruito. Non saprei dire il perché. Certo, io e il protagonista condividiamo almeno un frammento di passato; certo, abbiamo attraversato lo stesso timore e lo stesso fascino dello spaesamento, dell’indolente libertà di questa città, dei suoi ozi e dei suoi vizi. Però la reale natura di questa affinità, da cui credo sia scaturita questa associazione, mi resta sconosciuta, o quantomeno inconsapevole. Ho capito quindi che posso scrivere di me stesso, e cedere finalmente anch’io al lato oscuro dell’autobiografismo più sfrenato, ormai rampante nell’orizzonte narrativo nostrano.
Invece, Paparazzo ha un obiettivo. Non è un pessimo gioco di parole, ma un’affermazione di verità. Da bravo figlio di questa epoca, vuole immortalare il suo spirito creatore, quello che i tedeschi chiamano zeitgeist. Non è interessato a ritrarre la gente che indugia a passeggio, come fosse nella piazza del paese nei giorni di festa; no, lui vuole andare oltre, squarciare il velo. Vuole sventrare l’intima decadenza di questa società, che coltiva idoli la cui unica brama è quella di sfoggiare un conoscenza sufficiente per ritenersi colti e alla moda. Vuole santificare la loro compravendita esponendoli al sacrificio sull’altare della celebrità, rendendoli dèi e uomini a seconda dell’indice di gradimento. Vuole ritorcere l’arma suprema della volgarità contro di loro. È il prodotto di questa società della sensazione, certo, ma anche di un paradosso: egli diventa affermato e benestante mettendo alla gogna gente affermata e benestante, e il disagio dei suoi simili nell’esposizione mediatica è proporzionale al suo guadagno. Tuttavia, anche il vizio che tanto s’affanna a commercializzare, a Roma, è diventato un fatto di costume, una moda; la cosa più volgare e deprecabile è che il vizio è stato degradato alla sua semplice esibizione, lo slancio vitale relegato all’apparenza, più che all’autentico godimento. Che vergogna, cosa direbbero i nostri predecessori, coloro che hanno costruito e calpestato e rese vive queste stesse strade? Non ci sono più i vizi di una volta. Inoltre, se è vera la mia teoria del diorama, non c’è da escludere in tutta Italia sia così, almeno nei grandi centri urbani, con esclusione di qualche isola genuinamente peccaminosa, immersa nel mare magnum della provincia rurale.
Roma è un demone sornione e bonario, che corrompe anche il gusto del peccato.
Sono appena tornato da una piacevole serata in compagnia di amici. Non lo riporterei, se non fosse avvenuto un episodio che mi ha provocato un certo piacere e, al contempo, un certo dispiacere che non saprei bene identificare; in ogni caso, mi ha fatto molto ridere. Il fatto in sostanza è questo: alla cena era presente un editore, di cui non farò il nome per questioni pubblicitarie, che ospitava un ottimo scrittore inglese, di cui non farò il nome per questioni di etica lavorativa. Questo scrittore è anche traduttore e si dà il caso avesse tradotto, tempo addietro il nostro incontro, un libro in cui vengo citato da una scrittrice, di cui non farò il nome per questioni, diciamo, di par condicio, arrivati a questo punto. Il traduttore aveva tradotto il mio nome in Ennius Flaianus, pensando che fossi uno scrittore latino. Quando ci siamo incontrati in una trattoria romana, in questa tropicale sera di giugno, devo ammettere che è rimasto un poco deluso dalla mia persona: pensava fossi morto da almeno duemila anni abbondanti. Non si aspettava di poter conversare con un scrittore dell’alto impero. In realtà, andando oltre la dilatazione temporale, non è che si sbagli poi così tanto. Anzi, abbiamo convenuto che alcune caratteristiche della mia persona, nonché una mia certa attitudine alla vita, confermavano questa sua intuizione. È possibile che io non appartenga a questa epoca? Che io sia un antico romano, sepolto e conservato nelle derive del tempo, ripudiato dalla storia, rimasto ancora qui, a scrivere di cose che i miei contemporanei Catullo, Giovenale, Marziale, hanno scritto meglio di me? Direi che le probabilità sono buone.
— Alex Di Nicolò —